Grazie ad essa abbiamo svelato la struttura tridimensionale delle proteine e elaborato mappe precise di modelli climatici. Possiamo anche vedere dove l’occhio umano non arriva e creare repliche digitali precise, sia di monumenti storici che del nostro organismo. Probabilmente non potremmo più vivere senza questa tecnologia dirompente, ma cos’è esattamente l’IA? Come funziona e come impara? Quali sono i suoi utilizzi? Cosa ci aspetta in futuro? E, soprattutto, dove sta il limite?
Cosa intendiamo per IA?
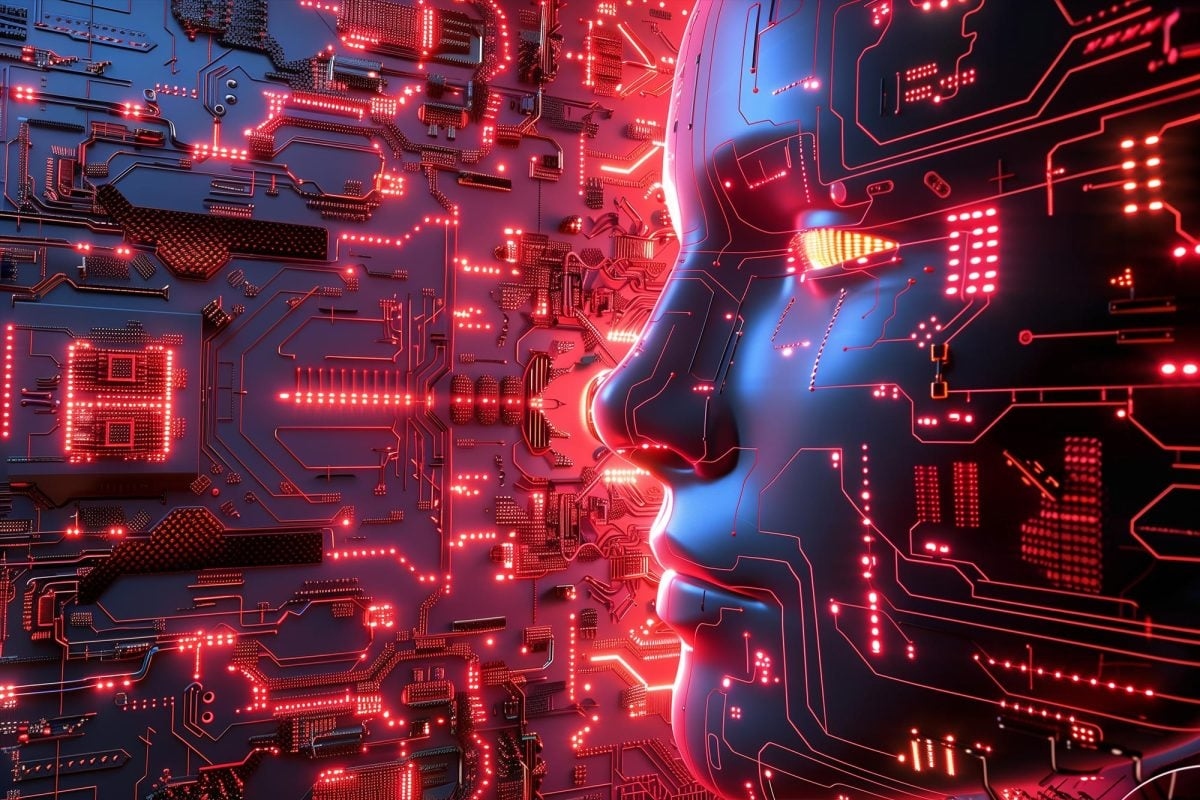
In linea di massima, per IA intendiamo la capacità delle macchine di imitare il modo in cui gli esseri umani apprendono e persino ragionano. In senso stretto, non esiste un’unica intelligenza artificiale, ma tante quante sono i modelli generativi. Tuttavia, tutte hanno una caratteristica comune: la capacità di replicare i processi cognitivi umani. che imitano seguendo uno schema chiamato apprendimento automatico, noto come “deep learning”.
Molto più di ChatGPT
“L’IA comprende numerosi rami. Ogni modello è unico ed è progettato per aumentare la nostra capacità di vedere e comprendere”, afferma il professor Lluis Nacenta, esperto di questa tecnologia dirompente.
“Vede ciò che l’occhio umano non vede. Coglie irregolarità, schemi invisibili a noi. Ci permette di vedere molto meglio, ricordare molto meglio, avere una capacità di collegare le idee molto migliore e prendere in considerazione molti più dati di quanto sia in grado di fare il nostro cervello… Tuttavia, dobbiamo ricordare che rimane una protesi. Ci costringe a ridefinire concetti che davamo per scontati. Ci mette di fronte alla nostra idea di intelligenza”, sottolinea l’esperto.
La macchina che impara da sola
Un concetto chiave per comprendere l’IA è quello di apprendimento profondo (deep learning). In realtà, si tratta di una branca del machine learning, molto più elaborata di quest’ultimo.
La differenza principale tra il machine learning tradizionale e il deep learning sta nella complessità delle loro reti neurali. I modelli tradizionali hanno solitamente uno o due strati, mentre i modelli di deep learning possono averne centinaia o addirittura migliaia, il che permette loro di apprendere modelli molto più complessi.
Inoltre, mentre il machine learning tradizionale necessita di dati ben organizzati ed etichettati per funzionare correttamente, il deep learning può lavorare con dati non strutturati e senza etichette. Grazie a ciò, è in grado di identificare autonomamente le caratteristiche importanti all’interno dei dati e migliorare i propri risultati nel tempo.
L’IA ci permette di vedere molto meglio, ricordare molto meglio e collegare le idee molto meglio
L’IA generativa è nata nel 2011, da Google Brain, il team di ricerca sul deep learning di Google AI, la divisione di Google dedicata all’IA. “Sono stati i primi a ottenere algoritmi chiamati transformers in grado di cercare riferimenti basati sul deep learning”, spiega a National Geographic l’ingegnere Manuela Delgado, divulgatrice e specialista in trasformazione digitale e tecnologie dirompenti, che da due anni lavora a progetti legati all’innovazione e alla tecnologia, compresa l’IA. “Tutti i modelli si basano sullo stesso principio, una sorta di ‘cervello sintetico’ che acquisisce un nome diverso a seconda dell’azienda che lo ha progettato.
”Un modo utile per comprendere meglio come funziona l’IA generativa è osservare come si è evoluto il modo in cui abbiamo interagito con questa tecnologia“, sottolinea Nacenta. Abbiamo iniziato ad addestrare le macchine a distinguere tra più immagini (ad esempio, i test Captcha, in cui è necessario selezionare determinate immagini da un riquadro). Prima insegnavamo loro a riconoscere un gatto. Ora abbiamo ribaltato il concetto, chiediamo loro di mostrarcelo attraverso una descrizione… ciò che intendiamo come prompt.
IA: il complemento di cui la scienza ha bisogno
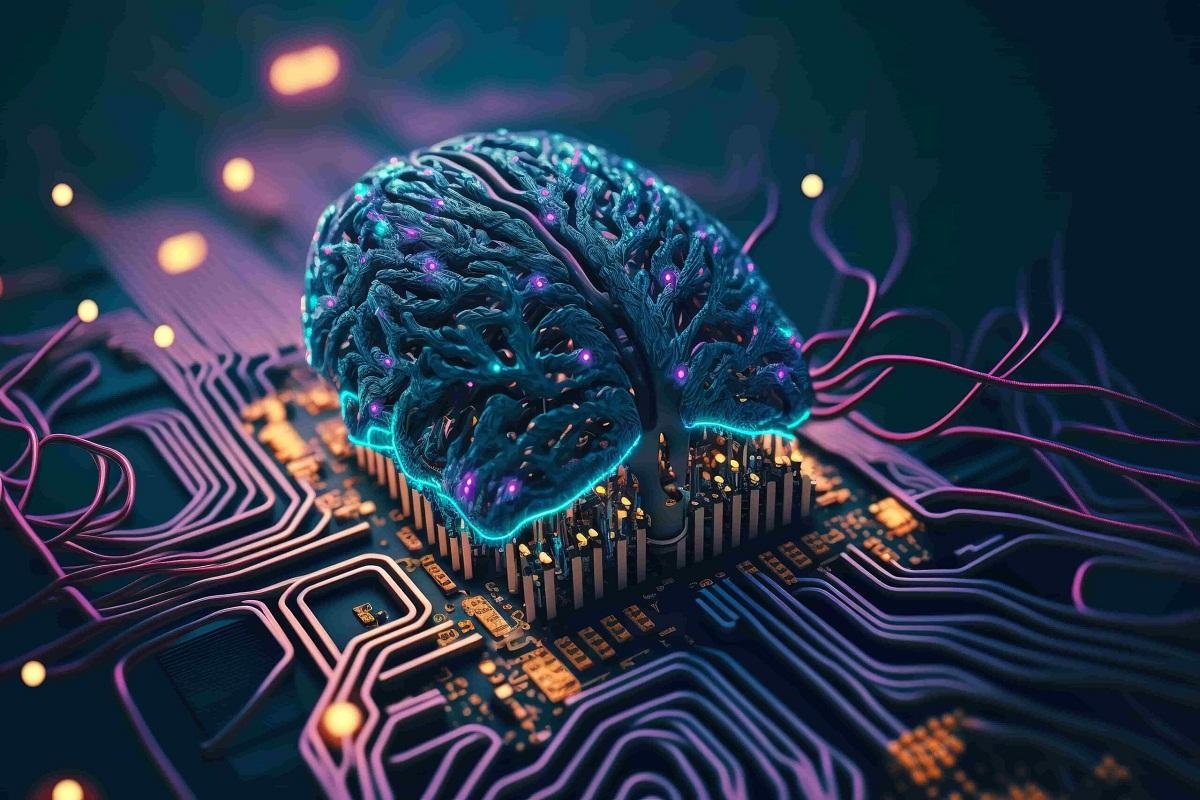
Ma gli algoritmi servono per molto più che generare testi o immagini. Nel campo della ricerca scientifica, questa tecnologia diventa un aiuto inestimabile, poiché, tra gli altri scopi, permette di raggiungere limiti prima insospettabili.
Può essere di grande aiuto nella diagnosi per immagini, ma è anche particolarmente utile in molti altri campi scientifici: alcuni analizzano grandi quantità di dati che servono per elaborare mappe climatiche, altri creano repliche digitali.
Gemelli digitali
I gemelli digitali sono come copie esatte, ma in formato virtuale. Possono essere un oggetto specifico, ad esempio un organo del corpo umano, o un intero sistema, ad esempio una città. È un processo simile a una simulazione, ma molto più complesso. La differenza sta soprattutto nella scala: mentre una simulazione studia generalmente un processo particolare, un gemello digitale può eseguire molteplici simulazioni molto utili per studiare molteplici processi.
Beatriz Eguzkitza è una delle scienziate che sta studiando il potenziale di questa tecnologia per scopi medici. In particolare, il suo progetto si basa sull’ottenimento di immagini ultraprecise delle vie respiratorie, che le consentono di condurre studi sull’effetto di possibili farmaci o persino di prevedere come potrebbe progredire una malattia come la fibrosi cistica.
L’ottenimento di queste rappresentazioni esatte da un organismo o da un tessuto offre infinite possibilità. Ad esempio, nel campo della ricerca contro il cancro, dove l’IA può svolgere un ruolo decisivo nell’ambito della diagnostica per immagini. “In molti casi, l’IA rileva ciò che l’oncologo non è in grado di vedere, quindi potremmo arrivare a un punto in cui gli esseri umani impareranno di più sul cancro grazie agli algoritmi che con le nostre ricerche”, afferma Nacenta.
Questo significa che l’IA può sostituire i medici? Assolutamente no. “Le macchine non diagnosticano, aiutano solo a diagnosticare”, sostiene l’esperto. Gli strumenti di IA possono aiutare a risparmiare molto tempo in compiti ripetitivi che rappresentano un collo di bottiglia in un sistema sanitario, ma non esentano da una revisione costante da parte del personale specializzato. In altre parole, gli algoritmi facilitano il lavoro dei medici, ma non lo sostituiscono.
